
Nonostante i progressi nella medicina moderna, le donne continuano a essere significativamente sottorappresentate negli studi clinici. Questa disparità ha profonde implicazioni sulla qualità e l’efficacia delle cure mediche offerte al genere femminile. Dalla farmacologia alla cardiologia, dall’oncologia alla neurologia, la ricerca continua a poggiare su un modello maschile standard, con ripercussioni gravi sulla diagnosi, la cura e persino la sopravvivenza delle pazienti.
L’allarme non è nuovo, ma i numeri più recenti, come riportato in un’inchiesta del Guardian del maggio 2025, confermano quanto la medicina resti lontana dall’aver colmato il divario di genere. Nonostante le donne rappresentino oltre il 50% della popolazione globale e siano spesso le principali fruitrici di servizi sanitari, sono sistematicamente sottorappresentate nei trial clinici. Questo squilibrio ha effetti concreti: farmaci meno efficaci, più reazioni avverse, diagnosi ritardate e una medicina che, letteralmente, non le considera.
Il problema strutturale: un’eredità del Novecento
Il punto di partenza di questa discriminazione ha radici storiche e politiche. Dopo lo scandalo del talidomide negli anni ’60, che causò migliaia di malformazioni congenite, la Food and drug administration (Fda) statunitense nel 1977 vietò l’inclusione delle donne in età fertile nei trial clinici di fase I e II. Una misura cautelativa che si trasformò, nei decenni successivi, in un’esclusione sistematica. Solo nel 1993 la norma venne formalmente abolita, ma l’inerzia scientifica e burocratica ha continuato a produrre effetti.
Ancora oggi, la maggior parte degli studi preclinici – cioè quelli condotti su animali – utilizza quasi esclusivamente topi maschi. Questo perché gli ormoni femminili, si sostiene, introdurrebbero “troppa variabilità”. Una giustificazione che tradisce un pregiudizio: la fisiologia femminile non è più complessa, semplicemente è diversa. Ma proprio questa diversità dovrebbe essere oggetto di studio, non un ostacolo alla ricerca.
La medicina standardizzata su corpi maschili
 Caroline Criado Perez, nel suo saggio divenuto un manifesto (Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men, Abrams, 2019), denuncia una verità scomoda: nella medicina il corpo maschile viene considerato la norma universale. Ogni deviazione da quel modello è vista come una complicazione. E questo avviene nonostante sia noto da decenni che le donne metabolizzano i farmaci in modo diverso, che i sintomi di molte patologie si manifestano in forma diversa, e che il ciclo mestruale può influenzare risposte terapeutiche e cliniche.
Caroline Criado Perez, nel suo saggio divenuto un manifesto (Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men, Abrams, 2019), denuncia una verità scomoda: nella medicina il corpo maschile viene considerato la norma universale. Ogni deviazione da quel modello è vista come una complicazione. E questo avviene nonostante sia noto da decenni che le donne metabolizzano i farmaci in modo diverso, che i sintomi di molte patologie si manifestano in forma diversa, e che il ciclo mestruale può influenzare risposte terapeutiche e cliniche.
In uno studio del 2020 pubblicato su Nature Communications, è stato osservato che il 70% degli studi preclinici sui farmaci non stratificava i risultati per sesso. Anche tra gli studi che includevano entrambi i generi, pochissimi analizzavano i dati in modo disaggregato. Il risultato è che molti farmaci sono dosati su un corpo di riferimento di circa 70 chili ignorando che il metabolismo femminile può richiedere dosaggi diversi.
Gli effetti clinici: più errori, più morti, più reazioni avverse
Le conseguenze sono considerevoli. Nel campo della cardiologia, ad esempio, i sintomi dell’infarto nelle donne sono notoriamente diversi rispetto a quelli degli uomini: più spesso nausea, dolore alla schiena o alla mandibola, stanchezza improvvisa. Tuttavia, poiché i trial storicamente si sono basati su popolazioni maschili, le linee guida diagnostiche sono state costruite su quei modelli. Risultato: le donne con infarto hanno il 50% in più di probabilità di ricevere una diagnosi errata, secondo uno studio del British Medical Journal del 2022.
Un altro esempio riguarda il sonno. Uno studio della Stanford University ha dimostrato che il farmaco zolpidem, comunemente prescritto per l’insonnia, permane nel sangue delle donne per più tempo. La Fda ha dovuto ridurre a posteriori il dosaggio raccomandato per le donne del 50%, ma solo dopo che erano emerse segnalazioni di incidenti stradali e intossicazioni.
Dati recenti: dove siamo oggi?
Secondo i dati del Global health 50/50 report 2023, solo il 40% dei partecipanti agli studi clinici approvati dalla Fda nel biennio 2020-2022 era di sesso femminile. In alcuni ambiti, come l’oncologia e la psichiatria, il divario è ancora più marcato. Nonostante le donne siano colpite più frequentemente da depressione, disturbi d’ansia o Alzheimer, gli studi clinici si concentrano ancora prevalentemente su uomini.
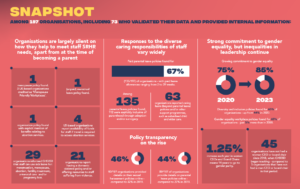
Un’indagine pubblicata su Jama internal medicine nel 2024 ha rilevato che solo il 32% dei principal investigators (i responsabili scientifici dei trial) sono donne. Questo squilibrio nella leadership della ricerca contribuisce a perpetuare l’orientamento androcentrico della medicina.
Gli ostacoli alla partecipazione femminile
Ci sono motivi pratici che contribuiscono alla scarsa partecipazione delle donne. Molti trial escludono automaticamente le donne in gravidanza, allattamento o in età fertile per timori legati alla responsabilità legale. Inoltre, le donne, soprattutto tra i 30 e i 50 anni, sono meno disponibili a partecipare a lungo a studi clinici a causa dell’equilibrio tra vita professionale e familiare.
Tuttavia, come sottolinea Criado Perez sul Gardian: «Non studiare le donne per proteggerle dai rischi significa lasciarle esposte a rischi molto maggiori quando quei farmaci verranno comunque prescritti, senza dati certi sulla loro sicurezza ed efficacia».
Le iniziative istituzionali: qualcosa si muove?
Ci sono però segnali incoraggianti. Negli Stati Uniti, l’ex amministrazione Biden ha lanciato nel 2023 un programma da 100 milioni di dollari per finanziare studi specificamente dedicati alla salute femminile. Anche se ora si temono le reazioni di Trump a riguardo. Il Nih (National institutes of health) ha introdotto l’obbligo di includere analisi disaggregate per sesso nei progetti finanziati.
L’Agenzia europea per i medicinali ha pubblicato linee guida per promuovere l’inclusione delle donne nei trial clinici. Il Parlamento europeo ha inoltre chiesto nel 2021 l’adozione di strategie mirate per promuovere la partecipazione femminile nei trial, evidenziando che una migliore rappresentanza migliora la qualità scientifica e la sicurezza dei medicinali.
A tal proposito, in alcuni Paesi europei sono state avviate iniziative pilota per coinvolgere maggiormente le donne. Ad esempio, in Germania il progetto “GenderMed-Wiki” mira a sensibilizzare ricercatori e clinici sulle differenze di genere e a promuovere protocolli di studio inclusivi. In Francia, l’Ansm (Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali) ha integrato criteri di rappresentatività di genere nelle procedure di valutazione degli studi clinici. Nel Regno Unito, poi, il governo ha annunciato l’intenzione di istituire una Women’s health strategy, con focus anche sulla sperimentazione farmacologica.
Verso una medicina di precisione (che includa anche il genere)
Oggi si parla sempre più spesso di “medicina di precisione”, cioè adattata al profilo genetico, ambientale e clinico del paziente. E la cosiddetta “medicina di genere” non è una medicina delle donne, ma una medicina che riconosce come il sesso biologico e il genere sociale influiscano su tutte le fasi della cura: prevenzione, diagnosi, trattamento e follow-up.
In Italia, solo recentemente alcune università hanno introdotto corsi dedicati, mentre l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) continua a denunciare l’assenza di dati disaggregati in molti ambiti sanitari. La questione della rappresentanza femminile nei trial clinici non è dunque solo un tema tecnico, ma politico e culturale. Una medicina che ignora metà della popolazione produce disuguaglianze reali, peggiora gli esiti clinici e mina la fiducia nelle istituzioni sanitarie. Dopotutto questo significa prendere decisioni cieche. E le decisioni cieche, in medicina, uccidono.
***
La newsletter di Alley Oop
Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.
Per scrivere alla redazione di Alley Oop l’indirizzo mail è alleyoop@ilsole24ore.com