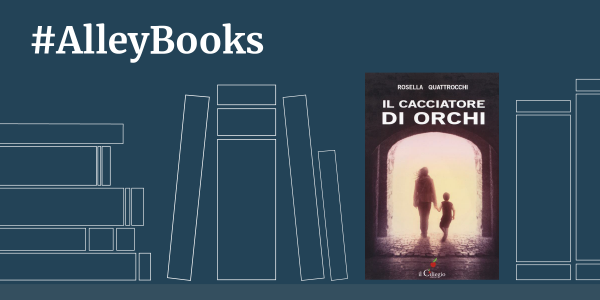Rosella Quattrocchi è un’assistente sociale che a Modena, da circa vent’anni, si confronta con il disagio. La abbiamo raggiunta alla Mondadori nel centro di Catania – a due passi dal Massimo Bellini, il teatro dell’opera – a margine di una delle presentazioni del suo ultimo libro, “Il cacciatore di Orchi“, uscito per Il Ciliegio nel 2019, poco prima della pandemia.
Il romanzo fitto e scorrevole, con uno stile spiccatamente descrittivo, racconta in 200 pagine la storia di Chiara. La protagonista è personaggio nato dalla creatività dell’autrice, ma insieme alter ego di lei. È nella prima tappa siciliana del giro ripreso dopo lo stop delle restrizioni dovute al Covid che la scrittrice ci spiega cosa significhi fare l’assistente sociale. E per farlo crea la suggestione di un’immersione della realtà che sapientemente cala nella finzione.
Da dove nasce “Il cacciatore di Orchi“ e perché?
A dire la verità il libro non nasce come romanzo, ma come soggetto per una serie tv. Viene fuori dall’esigenza di portare all’attenzione dell’opinione pubblica la figura dell’assistente sociale, da sempre poco e mal conosciuta, negli ultimi anni addirittura attaccata; mentre la mia è una “professione di aiuto”, esercitata da quanti desiderano affiancare chi si trova in difficoltà e volevo che passasse questo.
La storia raccontata è quella di una donna. Chi è?
Si chiama Chiara ed è un’assistente sociale. Di lei si capisce subito che è una donna appassionata che ama il proprio lavoro, che cerca di entrare in relazione con le persone che incontra, per offrire loro un servizio individualizzato e mai standardizzato.
Possiamo dire che Chiara lavora con il disagio. Come si fa?
C’è un obiettivo preciso che non bisogna smarrire e che è quello di aiutare le persone a trovare soluzioni, a migliorare la condizione di partenza. Si può quindi immaginare la frustrazione, le volte in cui invece si viene visti come ladri di bambini, pericoli da evitare, operatori da cui guardarsi, soggetti con cui è meglio non avere a che fare.
Si tratta di questo, di uno stereotipo. È questo lo scopo del romanzo?
Sì, principalmente volevo scardinare uno stereotipo, offrire al pubblico un’immagine più realista dell’assistente sociale.
Quanto c’è nel libro delle storie che ha incontrato?
C’è tutto e niente. C’è tutto nel senso che sono situazioni tipiche della mia professione. Abusi, maltrattamenti, evasione scolastica, separazioni conflittuali, perdita del lavoro, seconda generazione di immigrati: questi sono alcuni dei temi trattati e corrispondono a problematiche che incontriamo quotidianamente. Ma anche niente, nel senso che non ho mai tratteggiato nei personaggi del romanzo caratteristiche che potessero riportare a una persona reale, alla sua storia, alla sua situazione. Ho fatto una specie di collage delle decine e decine di storie che ho incontrato in questi due decenni e poco più di lavoro ho mischiato tutti gli ingredienti e costruito personaggi e storie di fantasie, liberamente ispirati alla realtà.
E poi a un certo punto la storia vira su Matteo. Chi è questo ragazzino di prima media? Cosa sappiamo di lui?
Matteo si sta affacciando all’adolescenza; ha terminato la scuola primaria e lo spaventa uscire dallo spazio sicuro che si era costruito. Ma soprattutto Matteo ha un segreto, inconfessabile, che vuole preservare e teme di non riuscire a farlo. È un bambino a cui gli adulti hanno messo sulle spalle un peso difficilmente sopportabile. È un bambino che non si fida più dei grandi, ma al tempo stesso spera di trovare qualcuno a cui poter affidare quel terribile segreto. Vuole fare il cacciatore di orchi, lui che l’orco sa bene chi sia. A un certo punto incontra Chiara e le loro strade convergono per un po’. Io ho conosciuto tanti Matteo, maschi e femmine, piccoli e grandi, durante il mio servizio. Temo però che tanti altri siano ancora nell’ombra, perché è difficile fidarsi quando sei stato ferito.
Parliamo, chiaramente, di abusi sessuali. Forte della sua esperienza, ci può dire se esiste un identikit della vittima?
È difficile tracciare un identikit, perché il fenomeno supera la classe sociale, la cultura e il contesto di vita. Molti anni fa lo si credeva un fenomeno ristretto alle classi meno abbienti, ma ormai da tempo è purtroppo riscontrato che sia un fenomeno trasversale. Questo rende molto difficile sia intervenire con la prevenzione che far emergere il fenomeno. Il fatto, inoltre, che l’abuso sessuale non si caratterizzi come un “classico” maltrattamento (non avviene con percosse, schiaffi o altro che il bambino possa facilmente identificare come violenza) e che sia spesso agito da persone di fiducia del bambino (con approcci spesso gentili, parole dolce, regali, carezze) lo rende di difficile interpretazione anche per la vittima stessa.
C’è quindi anche un problema di percezione?
Sì, chi subisce abusi spesso non comprende (o non subito) che si tratta di violenza. Per tornare alla domanda, è difficile tratteggiare un identikit, sia della vittima sia dell’aggressore. Meno complicato è delineare i segnali che devono farci mantenere alto il livello di attenzione, senza per questo giungere subito a conclusioni affrettate. È certo però che, ad esempio, i cambiamenti repentini e ingiustificati nel comportamento possono e devono farci intuire che il bambino sta subendo, dentro le mura domestiche oppure fuori, anche all’insaputa dei genitori, una qualche forma di abuso.
Qual è il tipo di approccio che serve quando si ha a che fare con la violenza agita sui minori?
Mai agire da soli, ma lavorare in rete all’interno dell’équipe del Servizio Sociale (in una squadra minima composta da assistente sociale e psicologo, possibilmente anche dall’educatore) e all’esterno (scuola, forze dell’ordine, autorità giudiziaria). Nell’approccio diretto col bambino poi bisogna essere adeguatamente preparati, sia dal punto di vista legale (sapere in che fase del procedimento ci si trovi) sia psicologico ed emotivo (non fare domande induttive e, anzi, rivolgere al minore il minor numero di domande possibile; ascoltare, accogliere, informare le autorità giudiziarie).
Si è fatta un’idea di come il sistema protegga i bambini dalla violenza assistita? Assistere ai maltrattamenti agiti da un genitore sull’altra figura di riferimento è subire un abuso che danneggia irrimediabilmente. Si incamerano schemi e modelli di comportamento, fino a ripeterli da adulti.
Sì, quel trauma giunge a distorcere la percezione della realtà e influenzare lo sviluppo futuro del bambino. Credo che a livello di sistema, se intendiamo i servizi socio-sanitari e i Tribunali, da alcuni anni la protezione sia correttamente agita (sono ormai frequenti le richieste di accertamenti da parte della Procura minorile a seguito di litigi tra genitori), ma a livello sociale ancora non si ha piena consapevolezza del danno che la violenza assistita agisce su un bambino. Ciò che aiuta è sicuramente il lavoro di équipe, il confronto costante e l’avvicinarsi ad ogni situazione con attenzione all’individuo. Questo, tra l’altro, serve a liberare le risorse di cui la persona dispone, nel suo contesto di vita: non offriamo risposte standardizzate in base al problema, ma lavoriamo insieme per cercare la risposta più adatta alla sua situazione specifica.
Ci sono errori che non dovremmo fare e ancora facciamo?
L’errore più grande è non considerarla violenza. Siamo arrivati a definirla tale solo abbastanza di recente e nella mentalità di molte persone se il bambino non è “toccato” fisicamente non c’è violenza. Spesso sentiamo genitori dire “non ha sentito”, “era nell’altra stanza”, “non si è accorto di nulla. Oppure, nel caso di un bambino molto piccolo, “ancora non capisce”. La violenza assistita non solo spaventa il bambino, ma gli fa del male.
Parliamo di soluzioni. Quanto è difficile cercare soluzioni al disagio sociale?
Il disagio sociale è una costante della storia dell’uomo. Si modifica nel tempo, come cambiano i contesti sociali, storici, culturali, ma quello permane e va affrontato. Il compito del Servizio sociale è fondamentale, è sia di azione che di coordinamento della rete sociale presente nei vari contesti e territori.
Da operatrice come definirebbe l’offerta di servizi sociali in questo Paese, partendo dalla sua esperienza che è quella di una Regione certamente virtuosa? Quali spazi di miglioramento vede?
Personalmente trovo che sia ancora troppo differente l’offerta da Regione a Regione e, anzi, anche da Comune a Comune. Il nostro sistema di welfare è certamente migliorabile. Bisognerebbe ad esempio applicare in modo più puntuale e uniforme le leggi che già abbiamo. Non dimentichiamo però che il nostro è uno dei migliori in Europa. Spesso colleghi di altri Paesi restano meravigliati dall’offerta di servizi che abbiamo in Italia. E lo stesso vale per la sanità.
Come definirebbe la preparazione degli operatori e delle operatrici rispetto agli abusi subiti dalle vittime della violenza domestica? C’è una corretta capacità di leggere il fenomeno o ancora oggi secondo la sua esperienza si sbaglia nel trattare questi casi, ad esempio mettendo in atto dinamiche di vittimizzazione secondaria?
Si compiono ancora tanti errori, la preparazione è scarsa ed è quasi interamente lasciata all’iniziativa personale. Credo che, almeno per quanto riguarda la mia professione, sarebbe necessario strutturare il percorso universitario con un triennio comune e un biennio di specializzazione, per problematica (per esempio violenza intrafamiliare, disagio giovanile/bullismo, interventi con persone malate e caregiver, immigrazione e integrazione eccetera), oppure per fascia di età (minori, adulti, anziani). Importante sarebbe poi, per i professionisti già inseriti nel mondo del lavoro, un percorso di formazione congiunta di tipo multidisciplinare, con gli operatori con cui quotidianamente o saltuariamente si lavora e che svolgono altre professioni, anche sotto altri enti. Questo permetterebbe, oltre a una reciproca conoscenza, anche un lavoro più omogeneo e capillare.
Nelle sue presentazioni ha incontrato e si è confrontata con colleghi di tutta Italia. Quanto conta fare rete? Vi siete detti che è questa la strategia giusta per affrontare il disagio?
Conta tantissimo ed è la strategia vincente. Conta fare rete sia tra colleghi che svolgono la stessa professione, sia, come dicevo prima, tra colleghi di altre professioni con cui si condividono aree di lavoro. Fare rete permette di unificare e allargare, interrompere la frammentazione di risorse e di risposte; permette di aumentare le risorse, di avere punti di vista più ampi. Fare rete anche oltre il proprio quotidiano professionale, confrontarsi con colleghi di altri Comuni e Regioni permette di scambiarsi prassi, idee, metodi che possono essere poi implementati nella propria realtà. E poi fare rete sul territorio: includere non soltanto i professionisti e chi accede ai Servizi, ma anche le realtà già presenti, sia istituzionali che non. Penso alle scuole, alle parrocchie, alle polisportive, alle tantissime associazioni di volontariato (solo nella mia città ce ne sono più di 200). Il lavoro di rete e il lavoro di comunità non solo utili soltanto al singolo intervento e progetto, ma rafforzano la realtà del territorio, creano connessioni tra le persone, sensibilizzano il contesto sociale.
Come Chiara anche lei nel suo lavoro teme l’assuefazione che nelle pagine del romanzo definisce “quel pericolo subdolo che fa apparire normali le condizioni aberranti”. Chi fa un mestiere come il suo, come affronta questo rischio?
Certo, anche tra gli assistenti sociali vedo il rischio di abituarsi a incontrare dolori e sofferenze, difficoltà e violenze e di alzare pian piano l’asticella della percezione del problema. Il rischio c’è, ma devo dire che raramente l’ho visto concretizzarsi. Piuttosto ho visto vari colleghi, dopo anni di servizio, cambiare lavoro proprio per evitare di ridurlo a mera esecuzione di prassi. La via è una sola: puntare all’individuo, centrare il lavoro sulla persona.
***
Titolo: “Il cacciatore di orchi”
Autrice: Rosella Quattrocchi
Editore: Edizioni Il Ciliegio
Prezzo: 13 euro
***
La newsletter di Alley Oop
Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.
Per scrivere alla redazione di Alley Oop l’indirizzo mail è alleyoop@ilsole24ore.com