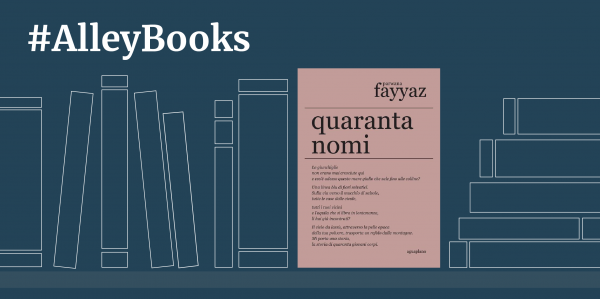La tomba degli imperi: così è soprannominato l’Afghanistan secondo un vecchio cliché, sia perché in molti hanno provato a conquistarlo senza riuscirci, sia perché, come nel caso dell’Unione Sovietica, invadere questo Paese incastonato nel cuore dell’Asia, crocevia di tradizioni e conquiste, fu l’ultimo atto prima del crollo definitivo. Dopo una lunga occupazione, durante la quale i sovietici non riuscirono domare la resistenza, sostenuta anche dagli Stati Uniti, le truppe si ritirarono nel 1989 e lasciarono un Afghanistan lacerato dai conflitti interni, politicamente radicalizzato e socialmente stremato dalla povertà. Nel 1994 poi, il mullah Omar, che aveva combattuto tra i mujaheddin, formò il gruppo islamista radicale dei talebani che nel 1996 prese il potere, per ritornare con rinnovata recrudescenza al governo dal 15 agosto 2021. Ora l’Afghanistan non esiste più: si chiama Emirato Islamico dell’Afghanistan.
Parwana Fayyaz era una bambina di Kabul. Aveva sette anni quando lo scoppio della guerra civile costrinse la sua famiglia a emigrare in Pakistan. Tornata a Kabul all’età di sedici anni, terminò lì gli studi superiori per poi iscriversi all’università di Chittagong, in Bangladesh, e successivamente a Stanford, in California, dove ottenne la laurea in letterature comparate e un master in scienze religiose. Sono seguiti il dottorato a Cambridge in letteratura persiana e il ruolo di ricercatrice nella stessa università, e nel 2019 ha vinto il Forward Poetry Prize, uno tra i più prestigiosi premi di poesia in lingua inglese. La poesia premiata è “Forty Names”, “Quaranta Nomi”. Un poemetto ispirato alla storia tradizionale di Gulaim, l’adolescente guerriera che difese antichi clan dagli invasori orientali con l’aiuto delle sue “qyrq qyz”, 40 ragazze. Una potente narrazione matriarcale che si erge da secoli nell’epica dominata dagli uomini dell’Asia centrale, e che fa da spunto al lavoro di Parwana Fayyaz.
La poetessa dà alle quaranta ragazze dei nomi, le veste di abiti colorati e sciarpe, restituisce loro un’identità e una rappresentazione concreta. “In Afghanistan le donne restano senza nome, conosciute solo in relazione agli uomini nelle loro famiglie”, scrive l’autrice sul blog dell’editore inglese: “Anche le loro lapidi non portano i loro nomi. Chiamare una donna per nome è un atto proibito, considerato irrispettoso e persino pericoloso. Questa poesia sfida quel tabù”. Alla luce di queste parole risulta più chiara la potenza deflagrante del componimento. Che però conserva tra le righe la forza combattiva, mentre l’elenco dei quaranta nomi si dipana con una dolce musicalità, tra rime oblique e sottili, tradotte con grande cura da Lea Niccolai.
Un colpo,
il padre apre la porta.
Là sono gli altri padri,
e i volti delle madri sussultano.
Le figlie stanno in piedi dietro di loro.
Nel fondo della notte oscura,
i loro colori, giallo e turchese,
rigano il cielo.
“Zibon, figlia mia,
portale alla grotta”.
Le diedero una lanterna
e lei fece strada.
Il gregge di colori le fluiva dietro.
La notte era lenta,
il suono dei passi la melodia solitaria di un mistico.
Attraverso i suoi versi, Fayyaz costruisce un microcosmo familiare e rurale in cui le storie individuali si fanno universali, accompagnando il lettore occidentale alla scoperta di villaggi e città, panorami e territori ignoti, orizzonti e tradizioni. E, nel contempo, la poetessa restituisce la voce a diverse generazioni di donne che si incontrano tutte nello stesso territorio: quello della memoria collettiva da cui sono state sradicate, in un’assenza di tempo e di spazio, dove l’esistenza è puro desiderio. E anche i nomi acquistano una valenza di testimonianza: la traduzione viene usata come un’arte in cui i nomi persiani si accompagnano come suoni ai nomi tradotti in inglese, micro-poemi che disegnano confini: Bakhti-Cavalca lupi, Sharbat Gula-Linfa di Fiore, Adeela-Donna Giusta. Ma nominare non è solo atto creativo dell’artista, è anche un’iniziativa individuale di autoaffermazione:
Il suo nome era Nadia.
Ma preferiva essere chiamata Anjuman.
Colei che Chiama e la sua Costellazione in un angolo,
la congregazione che non tace.
Si erano date il nome di circolo del cucito.
Tra loro, voci sconosciute trovavano ascolto.
Tra loro, poesia fioriva dall’invisibilità.
Fuori del cerchio, Nadia era prigioniera.
Nella sua solitudine, pregava in poesia.
La poesia di Fayyaz è una testimonianza compassionevole della vita delle donne e delle ragazze afghane. Per molte di loro, l’unica possibilità di esistenza sta nel silenzio e nella pazienza, private del nutrimento dell’istruzione, dell’arte e della letteratura, impossibilitate a fiorire ed esprimersi nella loro individualità. Madri, figlie, sorelle, amiche, sono tutte unite nelle opportunità mancate e nell’oppressione, esiliate, quando non geograficamente, umanamente.
Nella poesia di apertura della raccolta, “Three dolls“, Fayyaz racconta che sua madre durante la guerra costruiva per lei e le sue sorelle delle bambole, usando legnetti raccolti in giardino e scampoli di stoffa. Anche le bambole ottengono un nome, in un tentativo estremo di vivificazione che si chiude nell’amarezza dell’ultimo verso:
La mia, che aveva una gonna color verde regale, era la maggiore e la più alta,
e la chiamai Duur, Perla.
Shabnam scelse una gonna giallo splendente
e chiamò la sua bambola Pari, Angelo.
E la nostra sorellina, Gohar, prese una stoffa di un blu profondo
e chiamò la sua bambola Raang. Colore.
Vissero più a lungo della nostra infanzia.
***
Titolo: “Quaranta nomi”
Autrice: Parwana Fayyaz
Traduttrice: Lea Niccolai
Editore: Aguaplano, 2022
Prezzo: € 13,00
***
La newsletter di Alley Oop
Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.